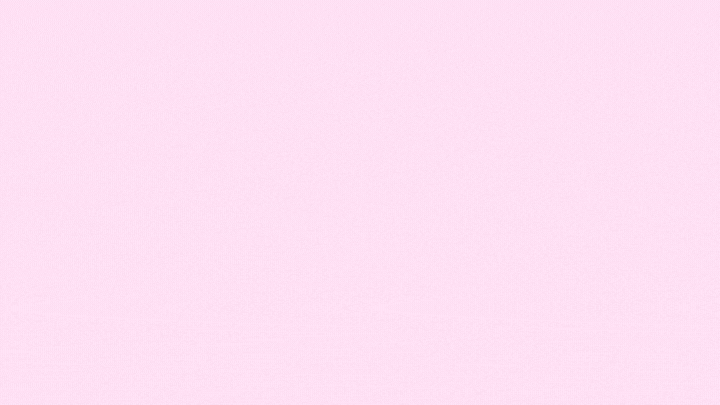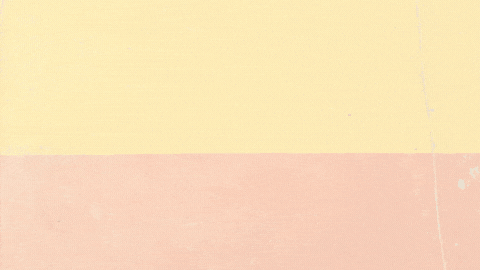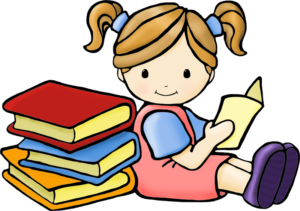In La signora scompare (1938), Hitchcock trasforma il treno in una scatola magica, illusionistica, nella quale si materializzano gli inganni che guidano l’evolversi della narrazione e lo sviluppo dell’intreccio. Su quel convoglio in partenza da Vandrika, nei Balcani, dopo la sosta in una pensione da operetta, viaggia una poliforme umanità tratteggiata talvolta ai limiti del caricaturale (ma senza mai perdere il sostegno della leggera ironia del regista): la ragazza che torna a Londra per sposarsi, i due oleografici gentlemen inglesi fanatici del cricket, una coppia di amanti clandestini, un etnomusicologo, molte spie e un mago italiano. Ogni personaggio è qualcosa di «altro» rispetto alla sua maschera apparente: l’arzilla vecchietta, ad esempio, è un agente del controspionaggio, e sia lo studioso che i due amanti del nobile sport inglese, indifferenti a ogni emozione proveniente da terzi, al momento opportuno si rivelano autentici uomini d’azione. È la teoria del doppio, insomma, che avvolge l’atmosfera di questo divertente film (che definire «di spionaggio» sarebbe estremamente riduttivo), mostrandosi simbolicamente proprio attraverso il fondo segreto del baule da mago che la coppia Iris-Gilbert scopre nel corso delle ricerche della signora scomparsa.
Una violenta nevicata ha bloccato l’unico treno in partenza della giornata costringendo i viaggiatori ad una forzata sosta in un albergo in cui vengono introdotti i protagonisti della vicenda. Oltre a Miss Froy, Iris (Margaret Lockwood) una bellissima donna alle soglie delle nozze (ma poco convinta), le sue amiche, Gilbert (Michael Redgrave) un antipatico musicista, Caldicott (Naunton Wayne) e Charters (Basil Radford) due signori inglesi preoccupati di perdere l’incontro di cricket in programma a Londra qualche giorno dopo.
Da manuale l’immagine di apertura, con l’obiettivo che dall’alto riprende il treno, la valanga, il paesaggio, fino a scendere progressivamente sino alla porta dell’albergo: un’unica carrellata per dare il quadro della situazione, senza alcun commento.
Quando, la mattina dopo, il treno riparte, Iris viene colpita da un vaso che cade e che era invece destinato a Miss Froy. Durante il viaggio Iris e Miss Froy fanno amicizia ma quest’ultima scompare improvvisamente. Una galleria oscura la carrozza, e quando la luce torna la donna non c’è più. Sparita, e come se non fosse mai esistita. Iris è sola contro tutti, poiché i passeggeri sostengono di non averla mai vista. La donna troverà proprio nel detestato Gilbert, il musicista maleducato, l’unico a prestarle ascolto. Dove è finita Miss Froy? Perché tutti negano di averla mai vista? E chi è veramente la simpatica vecchietta? Il mistero si infittisce, tanto più che lungo il viaggio sale a bordo un misterioso ammalato, completamente bendato, accudito da una suora alquanto dubbia…
Il doppio, l’occultamento della realtà è il filo conduttore con cui Hitchcock ordina i meccanismi della suspense, attraverso la concatenazione degli avvenimenti, in un treno che è a sua volta un baule magico dotato di doppio fondo, pronto a restituire Miss Froy non appena è possibile svelare il trucco: sotto le bende non c’è il vero ammalato, fatto salire a una fermata intermedia, ma la stessa arzilla vecchietta fatta «sparire» dai nazisti.
Il profilmico fa largo uso di modellini ferroviari e di trasparenti per rendere il senso del procedere del treno, come afferma lo stesso Hitchcock: «”La signora scompare” è stato girato nel 1938 nel piccolo teatro di posa di Islington, su di una piattaforma di trenta metri e con sopra un vagone. Il resto è stato fatto con degli schermi di trasparenza e dei modellini. Tecnicamente era un film molto interessante da fare». I risultati non tradiscono il regista: la dinamicità dell’azione è infatti tale da consentire una netta prevalenza di realismo, cui giova la continua presenza del ritmo ferroviario impresso dal senso di movimento simulato (i passeggeri sembrano «ballare» realmente su quelle carrozze) e dal cadenzato rumore di fondo.
L’ombra del nazismo grava su tutto il film, girato proprio nell’anno in cui Francia, Gran Bretagna e Italia sottoscrivevano il Patto di Monaco, con cui riconoscevano alla Germania il diritto a occupare i Sudeti a partire dal primo ottobre dello stesso anno. Ma quegli accordi furono un atto di debolezza delle diplomazie francesi e inglesi, che consegnarono a Hitler su un piatto d’argento la chiave per aprire, di lì a poco, le porte dell’Europa.
La signora scompare, come è stato fatto osservare, può essere considerato una sintesi di diversi generi cinematografici. Ma non si deve trascurare una lettura che ne evidenzi una più accentuata contestualizzazione storica, il suo carattere propagandistico e l’evidente avvertimento sui pericoli del nazismo e della guerra.
Nel 1979 Anthony Page ha proposto un remake di La signora scompare intitolato Il mistero della signora scomparsa, con Elliott Gould, Cybill Shepherd e Angela Lansbury, in cui la trama e la costruzione degli episodi del film precedente sono fedelmente rispettati. In entrambe le opere, nel complesso, il treno rivela tutto il proprio potere drammaturgico, proponendosi più come discreto co-protagonista che come semplice spazio scenico. Dal ritmo del viaggio, con le fermate e i diversi episodi di cui la narrazione è punteggiata, deriva poi un ideale contrappunto al già richiamato incalzare della Storia, fotografata in uno dei suoi più tragici momenti del Novecento.
La signora scompare (The Lady Vanishes, 1938)
Regia: Alfred Hitchcock
Soggetto: dal romanzo The Launder di Ethel Lina White
Sceneggiatura: Sidney Gilliat e Frank Launder
Fotografia: John Cox
Scenografia: Alec Vetchinsky
Montaggio: Alfred Roome
Musica: Louis Levy
Interpreti: Margareth Lockwood, Michael Redgrave, Paul Lukas, Dame May Whitty, Googie Whiters, Cecile Parker, Linden Travers, Mary Clare
Produzione: Edward Black
Origine: Gran Bretagna
B/N
Durata: 97’
_____________________________________________________
Roberto Scanarotti, giornalista e scrittore, ha pubblicato Treno e cinema. Percorsi paralleli (Le Mani editore, 1997), Aghi, Macachi e Marmotte – Dizionario semiserio per viaggiare in treno (ecedizioni, 2009), Destinazione immaginario – Andata e ritorno nell’universo simbolico della ferrovia (ilmiolibro.it, 2012) e Ultra vendeva noccioline (2013). Treno e cinema sono amici da sempre. Per l’esattezza dal 28 dicembre 1895, quando i fratelli Lumière – a loro insaputa – firmarono l’atto di nascita della settima arte portando in scena proprio un’inquietante locomotiva con alcune carrozze al traino. Da quel momento in poi, dopo letterati, poeti e pittori, anche i cineasti furono attratti dal fascino della ferrovia, e non ci volle molto tempo prima che il treno diventasse un celebrato protagonista degli schermi. Roberto Scanarotti svelerà miti e riti della ferrovia su celluloide, attraverso una serie di segnalazioni focalizzate su rail-movie e dintorni. Buon viaggio sui binari dell’immaginazione, dunque, anche ai pendolari che viaggiano ogni giorno su quelli reali e sono quindi poco sensibili alle suggestioni poetiche del mondo dei treni. Ma tant’è: parafrasando Bogart, bisogna pur ricordarsi che “è la ferrovia bellezza, e tu non ci puoi fare niente!”.